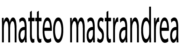BIOGRAFIA
Home > Biografia
Matteo Mastrandrea vive e lavora a Firenze. Ha iniziato a dipingere giovanissimo. Nel 1992 dopo il conseguimento del diploma in Grafica Pubblicitaria, attraverso alcune collaborazioni professionali ha modo di sperimentare concetti, colori, forme. Nel 1998 si Laurea all’Accademia di Belle Arti di Firenze e sceglie di dedicarsi alla pittura. Il Maestro e mentore a cui guarda è Gustavo Giulietti, che lo aiuta a sviluppare uno stile personale.
La sua arte si concentra sull’astrazione, dove utilizza forme, colori e texture per trasmettere sentimenti e stati d’animo permettendo a ciascuno di interpretare le opere in base alle proprie esperienze e percezioni. Ogni suo dipinto è un viaggio, un’esplorazione di emozioni e concetti che vanno oltre le parole.
‘Teo’ Mastrandrea
In Italia, e in Toscana, è caratteristico nell’ambiente naturale il tipo di vegetazione descritto come “macchia mediterranea”; in essa la libera natura ha espresso un complesso interagire di fratte, cespugli e roveti, spineti, sterpeti, selve e boscaglie con rare aree prative e diversi caratteri del suolo, assolato in collina, e aspro di forre e di gole ombrose e buie, fortemente differenziato nel sistema orografico e altimetrico, che dove abbia subito pochi interventi dell’uomo ha conservato, nell’alternarsi delle stagioni, fra i “sempreverdi”, la spontaneità del fiorire, e appassire, seccare, e rifiorire. Ecco fornita l’occasione al viandante in quei lidi, di raccogliere dalla primavera all’estate fiori e frutti spontanei, e magari in autunno, rami e foglie ingiallite, farne un bel mazzo da portare a casa e collocarli in un vaso senz’acqua per farli seccare. Il vaso conserverà a lungo l’immagine di quel mondo e diventerà il ricordo, o il simbolo stesso di un ricordo.
I fiori e i rami, si dirà, non erano nati per finire in quel vaso, immagini residuali della loro spontanea vitalità di quell’ambiente. Possiamo trovare tuttavia una analogia fra le immagini spontanee del mondo ideale impresso nelle pitture di Matteo Mastrandrea, che, raccolte in una mostra, ‘sono’ simboli, accostati perché siano comunicativi oltre il loro fine organico di gesti in sé nascenti: naif. (Naif, per la cultura della critica d’arte è il termine che ha definito la fortuna di una certa area di spontanee oggettivazioni artistiche visuali). Quando verifichiamo che alla ‘macchia mediterranea’ si oppone il costruito, la rete delle infrastrutture viarie, dei ponti, delle ferrovie, dei sistemi urbanistici, che la chiudono in un residuo di sé, e tuttavia ne possiamo valutare ancora la forza resistente, necessaria e ribelle. Nei sistemi urbanistici a gestione nazionale, regionale, provinciale, fino alle recinzioni private, riconosciamo il luogo nel quale anche la spontaneità naturale del mondo viene imbrigliata.
La spontaneità delle opere di Teo che ha preso la dimensione “forzata” nel luogo della mostra, viene dopo che lo spirito della sua anima abbia preso nell’attività del pittore la dimensione condensata del “quadro”, e notiamo proprio la scelta del “quadrato” geometrico che sia supporto alla figura, dove gli angoli sono retti e i lati fra di loro uguali. Teo si trova bene ad interagire con uno spazio fortemente equilibrato, quasi cristallizzato. Qualche altra espressione nei limiti di altri formati e proporzioni, di quelli che la critica seguita a chiamare – e noi tutti con essa – impropriamente, “quadri”, mentre dovremmo chiamarli rettangoli, cerchi, e così via, tutte costrizioni e concezioni spaziali di base, che possono essere comunque utilizzate dal pittore, rinunciando a qualcosa di per sé espressivo. La spontaneità ‘naif’ di Teo si esprime in rappresentazioni che sono ciascuna una ontologica rappresentazione di sé, una riflessione iniziata nella forma rivolta al guardare “dentro di sé”, e sviluppata nella coerente non facile arte del comunicare un’anima candida. Ne sorte fuori che il suo indagare la propria essenza è un atto di fede, che con mezzi concreti vuol rendere conto all’altro da sé, fruitore dell’opera (l’altro essere umano necessario per essere Specie) di un sentirsi corporalmente non affamato e non sazio, sapendosi corporale quel tanto da poter essere un animo percepito con gli occhi.
Ma altrettanto la sua essenza, scorra dall’area fantastica del dipingere profumi e suoni, sentimenti, echi e risonanze, e consista nel dar forma a processi tattili e gestuali del costituirsi in immagini surreali perché spirituali. Un percorso che le religioni hanno qualificato non riducibile al solo termine iconografia, ma necessariamente esteso alla conquista della ben più complessa iconoteologia. Una scrittura di immagini di profonda valenza teologica e religiosa.
Le immagini di Teo sono immagini sognanti e sognate, di fantasia e ragione, poesia e grazia, tese al confine finalistico, teleologico, tra il consapevole conscio filosofico, e l’inconsapevole inconscio psicanalitico, ma soprattutto afferrate e innalzate e in quel momento brandite come armi iconoteologiche che coraggiosamente invadono il campo della fede.
La versione sintetica e contemporanea della relatività ristretta, oggi quadridimensionale nell’aver ridotto lo spazio al tempo, e il tempo allo spazio, quel campo che in passato fu profondo nelle tre dimensioni e rese grandi nel primissimo Quattrocento fiorentino i voti e le offerte consapevoli del laico Guido di Piero, poi domenicano frate Angelico, come traduttore dello Spirito in Pittura. E, attenzione, che non si tratta qui di avere inventato un irriverente, forzato paragone fra i pittori; il contenuto di fondo, ne siamo certi, è infatti il medesimo. La pittura come fede.
Il critico che volesse descrivere, opera per opera, segno per segno, traccia, velo o massa di colore, valore timbrico o tonale nello spazio, il suo portato mistico, priverebbe ogni opera della sua stessa esigenza di anelito, la necessità di proiettarsi nel lungo tempo necessario alla assimilazione riflessiva dell’essenza fondante della religione, che sappiamo essere l’amore. Ancora il campo di pertinenza delle immagini alle quali ancora oggi si dedica l’arte della Persona, in attesa dell’arte della Specie. Noi, volentieri, ce ne asteniamo di fronte alla spiritualità dei lavori di Teo.
A cosa ci troviamo di fronte, teologicamente, ce lo dice il filosofo Ludwig Feuerbach nel suo scritto “L’essenza del cristianesimo”, di cui riportiamo una pagina densa:
«L’altra vita non è altro che la vita in armonia al sentimento e all’idea che questa vita contraddice. Nessun’altra funzione ha l’al di là se non quella di abolire questo disaccordo, di realizzare uno stato conforme al sentimento, in cui l’uomo sia in armonia con sé stesso. Un al di là ignoto è una ridicola chimera: l’al di là non è altro che la realizzazione di un’idea conosciuta, l’appagamento di un’esistenza nota, l’adempimento di un desiderio; non è che l’abolizione dei limiti che su questa terra impediscono all’idea di essere realtà. Dove sarebbe il conforto, dove il significato dell’al di là, se guardando ad esso non vedessi che notte buia? No! là io vedo sfavillare come oro puro ciò che quaggiù appena riluce come impuro metallo. L’al di là ha un significato, una ragione d’essere, unicamente in quanto è la separazione del metallo dalle impurità di cui è frammisto, ossia la separazione del bene dal male, del piacevole dallo spiacevole, del degno di lode dal degno di biasimo. L’al di là è la festa nuziale che congiunge l’uomo alla sua amata. Da lungo tempo egli la conosceva, da lungo tempo si struggeva di desiderio, ma circostanze esteriori, la realtà ostile, gli impedivano di congiungersi a lei. Nel giorno delle nozze la sua amata non diviene un altro essere; come potrebbe altrimenti desiderarla così ardentemente? Essa in quel giorno diviene soltanto sua, da oggetto del desiderio diviene un possesso reale. Su questa terra l’al di là è indubbiamente solo un’immagine, ma non un’immagine di cosa lontana e ignota, bensì una rappresentazione fedele dell’essere che l’uomo fra tutti presceglie e ama. Ciò che l’uomo ama è la sua anima.»
Credere e sperare è il messaggio di Matteo Mastrandrea, trovatosi coinvolto con tutti noi nella fase in cui la filosofia si è confusa e dissolta nella religione, concluso il proprio ruolo storico. Teo è il pittore che ha percepito ed esprime questa fase.
Fiorenzo Copertini Amati